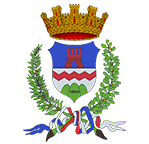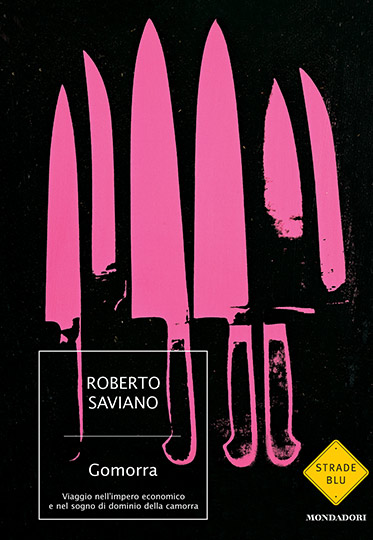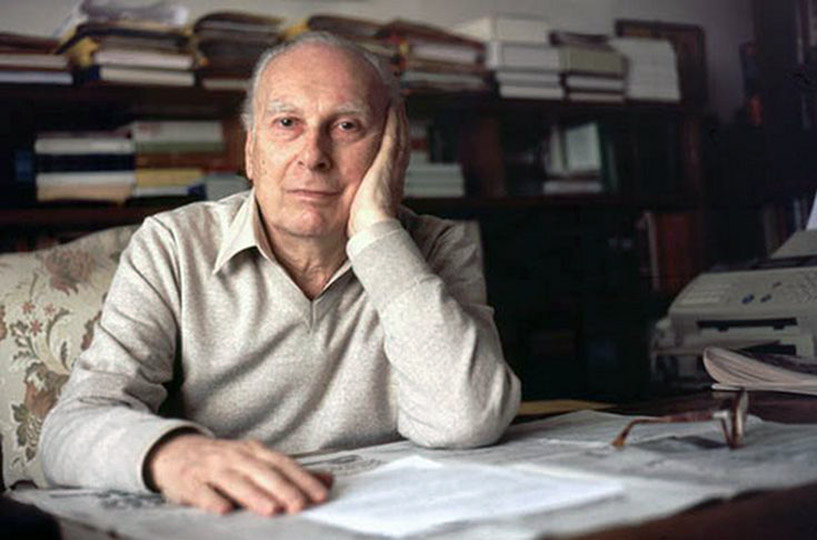Gomorra 2007
Alla fine di gennaio del 2005, la periferia nord di Napoli si riempì di giornalisti. Era scoppiata la faida tra il clan camorrista dei Di Lauro e gli scissionisti guidati da Gennaro Marino: i riflettori dei media, dopo decenni di silenzio, si erano accesi all’improvviso sul mondo della criminalità organizzata che non aveva mai smesso di dettare legge tra Secondigliano e Scampia.
Quel mondo, Roberto Saviano lo osservava da anni, e da dentro. Con la continuità infaticabile di chi non si ferma alla superficie dei fatti e con lo sguardo lucido ma non imperturbabile di chi sa che «comprendere gli elementi del disastro […] significava almeno farne parte». Gomorra è il risultato di questa volontà di capire e insieme della consapevolezza che «non […] sia fondamentale osservare ed esserci per conoscere le cose, ma è fondamentale esserci perché le cose ti conoscano».
Dall’osservatorio scomodo di chi non può permettersi neutralità e distanza oggettiva, Saviano racconta il mondo della camorra, ricostruendo con puntualità la topografia, la morfologia e la coerenza interna di un “sistema” criminale che è prima di tutto un sistema economico, la cui organizzazione si innesta e può contare però, per realizzare i propri fini, sull’inossidabilità di una mentalità atavica .
Se ne può dipanare la matassa seguendo il bandolo del sangue, sgranando il rosario degli omicidi, decifrando sui corpi martoriati degli uccisi le regole e il linguaggio dei clan; e Saviano non si sottrae al dovere di narrare l’orrore. Ma sa anche che il vero capo della matassa è altrove: nelle tonnellate di merci “fantasma” che transitano ogni giorno, non viste, dal porto di Napoli; nel controllo capillare esercitato dai clan sulle forniture dei negozi e dei cantieri edili; nel gigantesco volume d’affari mosso dal traffico internazionale di droga e di armi. «Se riuscissero a non scappare – scrive Saviano a proposito dei giornalisti accorsi da tutta Italia in quel 2005 per documentare frettolosamente la strage – si accorgerebbero di avere dinanzi i pilastri dell’economia, la miniera nascosta, la tenebra dove trova energia il cuore pulsante del mercato».
E’ questo il suo filo di Arianna nel labirinto della camorra, quello che gli permette di denudare la struttura della rete criminale, parallela alla legalità e allo stesso tempo ad essa intrecciata, e di svelare le ragioni della sua forza e della sua capacità di penetrazione. La camorra non è soltanto il residuo malato di una cultura arcaica; al contrario, «la logica dell’imprenditoria criminale, il pensiero dei boss coincide col più spinto neoliberismo». Per garantirsi il controllo di interi quartieri si ispira meno alla legge delle armi che a quelle dell’economia di mercato.
Con la sua discesa all’inferno, Saviano ci consegna una mappa del male che è insieme un saggio socio-antropologico e un’inchiesta documentata fin nei dettagli, ma dove il groviglio della realtà viene a snodarsi anche in trama romanzesca e può evocare il “romanzo delle stragi” di Pier Paolo Pasolini per lo scandaglio delle «ragioni e irragioni» da cui risulta raccordato «tutto ciò che non si sa o che si tace».
« Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi», scriveva Pasolini sul «Corriere della Sera» nel 1974. A distanza di trent’anni, Saviano può riprendere e variare così quell’atto d’accusa: «Io so e ho le prove. E quindi racconto. Di queste verità». Il suo furor conoscitivo e l’incandescenza linguistica che ne discende costituiscono una lezione di passione civile e di ricerca di verità, attraverso la scrittura e a prezzo della propria sicurezza, cui va il riconoscimento del Premio Omegna come alto esempio di odierna resistenza.
La volontà di capire, così tenacemente incalzante e vigile, è tale da risultare visceralmente contagiosa per il lettore. Sarebbe auspicabile che, con la ‘scorta’ di questa indagine accanita e della sua tensione, si coagulasse anch’essa in sistema, per contrastare l’impermeabilità alla banalità pervasiva del male.
Premio Scaffale
Carlo Spartaco Capogreco per “Il piombo e l’argento” – Donzelli
La magistrale ricostruzione della vicenda di Dante Castellucci, comandante del battaglione “Guido Picelli”, ucciso in seguito a una condanna a morte decisa ed eseguita, dopo un processo quantomeno singolare, dal comando unico della Prima Divisione Liguria ad Adelano di Zeri, provincia di Massa Carrara, consente al lettore contemporaneo di calarsi, quasi in presa diretta, nella vita partigiana, che ci viene riconsegnata in tutta la sua complessità. Non solo, ma apre squarci significativi su come è stata gestita negli anni la memoria di quegli eventi, dai protagonisti, consapevoli e inconsapevoli, e dalle istituzioni che su quella memoria hanno costruito la loro legittimità.
L’abilità con cui Capogreco maneggia le fonti, raggiungendo un equilibrio raro tra testimonianze orali e documenti scritti, che si rafforzano a vicenda senza venire mai polemicamente contrapposte fra loro quasi ci fossero due storie, come troppo sovente accade, e la scrittura scorrevole, mai appesantita da un uso eccessivo delle note, che evita al libro di essere confinato alla lettura esclusivamente professionale, hanno trasformato un eccellente progetto di ricerca in un’avvincente ricostruzione di una vicenda umana in cui destini individuali e processi storici si trovano inestricabilmente intrecciati.
Seguiamo così Dante Castellucci dalla Calabria alla Francia, dove la sua famiglia emigra quando ha solo due anni, al rientro a Sant’Agata d’Esaro a diciannove anni, dove conosce Otello Sarzi, che sta scontando una condanna al confino; dalla chiamata alle armi che lo porterà in Russia alla scelta partigiana, maturata già il 25 luglio del 1943 e condivisa da subito, tramite Sarzi, con i fratelli Cervi, con cui sarà catturato; dalla rocambolesca fuga dalla Cittadella di Parma, dove era stato imprigionato dai fascisti della Repubblica sociale, alla fuga dai compagni del partito comunista di Reggio Emilia, che lo condannano a morte ritenendolo una spia; dal credito condizionato dei compagni del partito comunista di Parma, al comando del battaglione “Picelli”; dall’eroica battaglia di Lago Santo parmense alla spietata e ingiusta fucilazione di Adelano.
Ma questi eventi non si svolgono nel vuoto, su cui troppo spesso sono sospese le ricostruzioni delle vicende partigiane. Sono, invece, radicati e determinati all’interno di processi storici, che Capogreco tratteggia e ricostruisce con mano sicura. Così, siamo accompagnati dentro gli aspri contrasti interni al partito comunista di Reggio che segnano tutta la vicenda dei fratelli Cervi, la cui ricostruzione oggi, alla luce della trasfigurazione mitica di quella vicenda, genera qualche inquietudine e permette, però, di capire tutti i limiti e le difficoltà che ha dovuto scontare la memoria della Resistenza nel trovare uno spazio sicuro e condiviso nella storia dell’Italia repubblicana. E soprattutto – elemento portante del lavoro di Capogreco – siamo introdotti nello scontro che prende forma nell’estate del 1944 dall’azione dei partiti del Cln, che prendono il comando delle bande, per costruire un esercito partigiano sottoposto a una consapevole guida politica. Un passaggio inevitabile e che rafforzò complessivamente il movimento resistenziale, ma al prezzo di lacerazioni mai ricomposte con i protagonisti della prima fase della Resistenza, quella delle bande nate spontaneamente dopo l’8 settembre, caratterizzate da spinte altamente ideali e da azioni coraggiose, anche se non di rado mal calcolate. E sullo sfondo di questo conflitto emerge con forza un tratto comune ad alcune culture politiche protagoniste della Resistenza, tratto esasperato dalle drammatiche condizioni di una guerra come quella, che consisteva in un’idea totalizzante della politica, per la quale i progetti di riscatto collettivo non possono tenere conto dei destini individuali, e sono autorizzati a spezzarli, quando sono ritenuti di ostacolo.
Idea che condiziona pesantemente anche le vicende successive alla fine della guerra, ricostruite da Capogreco con grande capacità di aderire alle complesse personalità dei protagonisti, fino all’incredibile decisione di chiudere la questione assegnando nel 1963 una medaglia d’argento alla memoria di Castellucci, per essere stato ucciso «dal nemico […] avendo rifiutato di arrendersi». Una decisione che, oltre a oltraggiare la memoria di Facio, rappresenta un falso in atto pubblico.
Premiando questo lavoro, vogliamo anche premiare, in ultimo, la tensione civile che ha mosso Capogreco, nella convinzione comune che «il mancato coraggio e la mancata determinazione necessari per indagare sino in fondo sulle responsabilità e i retroscena del processo-farsa di Adelano di Zeri non hanno portato acqua a nessuno. Tanto meno agli ideali della Resistenza». Perché siamo convinti che quando si hanno buone ragioni, non si può avere paura della verità.
Giovanni Fasanella e Sabina Rossa per “Guido Rossa, mio padre” – Bur
All’alba del 24 gennaio 1979 viene ucciso nella sua auto Guido Rossa, operaio dell’Italsider di Genova, sindacalista e militante del PCI, “reo” di aver denunciato un “postino” delle Brigate Rosse. Sabina, sua figlia, ha 16 anni. Quella mattina esce di casa per andare a scuola. Passa vicino all’auto del padre, ma non vede, chiuso lì dentro, il suo corpo senza vita. Piano piano, col passare delle ore, intuisce che è successo qualcosa, ma non vuole capire. Sarà sua madre a dirle “hanno ammazzato papà”. Sabina si chiude in se stessa, domanda una cosa sola: “Chi è stato?” “Le Brigate Rosse”.
Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica, dopo i funerali, ai quali partecipa una folla di 250.000 persone, dichiara: “Ho visto la vedova, i familiari angosciati, ma specialmente colpisce la figlia che si rifiuta, si ribella ad accettare questa morte. Non ha una lacrima, nulla, ma il dolore più lancinante ce l’ha nell’anima.”
Ribellione, rifiuto e dolore Sabina li tiene per sé, tacendo per più di 25 anni. Poi decide che è venuto il momento di cercare di capire il perchè e il come di quella morte, di quell’omicidio, che per alcuni brigatisti è stato “un incidente”, e che comunque ha lasciato lei, adolescente, senza l’amato padre, e che ha privato la società genovese, le fabbriche genovesi, di un militante politico e sindacale molto stimato, di forti convinzioni, di ineguagliato impegno e di grande coraggio.
Per un anno e mezzo, Sabina legge gli atti giudiziari, articoli di giornale dell’epoca; incontra magistrati, compagni di lavoro e di militanza politica del padre, numerosi ex brigatisti, dei quali uno faceva parte del commando che uccise Guido Rossa.
Una vera inchiesta, quella condotta da Sabina Rossa, con l’aiuto del giornalista Giovanni Fasanella. Un’inchiesta che getta nuova luce su un attentato le cui motivazioni e le cui modalità di esecuzione non erano state ancora chiarite appieno, ma anche sulla figura di suo padre e sul ruolo che effettivamente svolse nella lotta contro la presenza dei terroristi, o dei fiancheggiatori dei terroristi in fabbrica. Un’inchiesta che, come tutte le vere inchieste,lascia anche aperti dubbi e interrogativi.
Questo lavoro si traduce in una narrazione efficace e compatta, che coinvolge e commuove, soprattutto per la sua analitica lucidità, per il suo essere dolente, ma sempre senza odio e rancore.
Sabina stessa spiega il suo stato d’animo raccontando del suo incontro con l’ex brigatista Nicolotti: “… Da dietro la sua corazza, vedo affiorare la sofferenza … Che cosa ho pensato in quel momento? Che la sofferenza altrui, anche se frutto di un vissuto autonomamente scelto, fatto anche di violenza e di sangue, non possa e non debba costituire motivo di soddisfazione, di risarcimento nei confronti di chi è stato vittima di quei comportamenti e a causa di essi ha enormemente sofferto. Questo ho pensato. Che fosse giusto condividere la sofferenza attraverso il dialogo e il confronto”.
Con questo approccio Sabina ci ha regalato davvero un bel libro e ha eretto un grande monumento alla memoria di suo padre, che Giorgio Amendola in una lettera paragonava ai caduti partigiani, anch’essi “morti per compiere un dovere, non perchè costretti da una forza esterna, ma perché mossi da un’intima convinzione” e di fronte al quale noi possiamo condividere lo stupore di Piero Calamandrei, che ripercorrendo la vicenda di un eroe della Resistenza, scrisse: “Dunque nel mondo possono nascere ancora uomini così: dunque il mondo non è finito…”.
Per tutto questo la Giuria assegnando a questo libro il Premio Scaffale, intende da un lato segnalare un’opera che dovrebbe essere letta da tutti coloro, in particolare dai giovani, che vogliano chiarirsi le idee intorno a un episodio e a un periodo doloroso della nostra storia recente e, dall’altro, tributare grande riconoscenza soprattutto a Guido Rossa, caduto come i nostri partigiani per difendere la nostra democrazia, ma anche a sua figlia Sabina, che ha ereditato dal padre la passione e la tenacia per l’impegno politico e civile.
Marco Rovelli per “Lager italiani” – Bur
I CPT, centri di permanenza temporanea, come ogni genere di campo, nascono da uno stato di emergenza, di eccezione e non derivano dal diritto penale ordinario né da quello carcerario, ma anzi sono luoghi di detenzione in cui l’ordine giuridico, per gruppi sociali pericolosi e «da emarginare», è sospeso. Oggi è la popolazione migrante il gruppo potenzialmente deviante su cui esercitare prevenzione e contenimento in una logica di costante allarme sociale. Con un testo che mescola narrativa e saggistica, storie narrate in prima e in terza persona, poesie e note storico-giornalistiche, Marco Rovelli racconta questi luoghi di segregazione e violenza, racconta un’Italia che non conosciamo se non per averne letto sporadicamente sui giornali quando l’emergenza si fa più acuta: «Provate a chiedere in giro quanti sanno cosa sono i CPT, quanti sanno che esistono nelle nostre città dei lager dove si rinchiude qualcuno solo perché è un migrante, senza che abbia commesso alcun reato», scrive Rovelli nella sua nota introduttiva.
E così Rovelli ci offre un libro fatto soprattutto di storie raccolte nei campi, di voci ruvide che si raccontano, che mettono in scena fatti accaduti in altri luoghi a comporre un puzzel di vite alla deriva nelle sacche sottratte alla vista del nostro tempo. La seconda parte del libro è costituita di “note deperibili”, informazioni sulle politiche migratorie, sulla legislazione che le regola, sui singoli campi e sulla loro gestione, a misurare la distanza tra l’esclusione e il diritto.
Rovelli si propone in primo luogo di “salvare voci”, perché «Portare allo scoperto, creare reti, dare parola», testimoniare insomma, è una delle poche forme di resistenza possibile. Per questa ragione gli viene assegnato il Premio Scaffale nell’ambito del Premio Letterario”Della Resistenza” Città di Omega 2007.